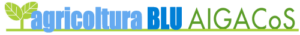Emissioni dal campo
Tuttavia, l’unità azotata oltre a essere costata molto in termini di emissioni in fase di produzione e allocazione, emette una quantità quasi altrettanto significativa di gas serra in fase di utilizzazione.
La fase di distribuzione sul campo del fertilizzante mediante spandiconcime o attrezzo analogo genera costi, sotto questo profilo, irrisori (indicativamente inferiori ai 20 g CO2/kg N), mentre è proprio il concime distribuito sul terreno che causa l’emissione diretta di protossido di azoto.
Nel suolo il protossido di azoto è emesso come sottoprodotto delle reazioni di nitrificazione (che portano alla formazione di nitrati che sono le forme azotate più facilmente assorbibili dalle piante) e anche in quelle di denitrificazione (che portano alla liberazione di azoto gassoso molecolare). Queste reazioni sono per lo più mediate da microrganismi.
Le emissioni di protossido di azoto dal terreno agricolo, espresse come CO2 equivalente, si attestano normalmente a valori superiori a 1,0 kg CO2 eq/kg di N ureico. Si stima infatti che una percentuale compresa fra 0,5 e 1,5% dell’azoto ureico distribuito possa essere trasformato in questa molecola. In questo caso la variabilità è data dalle condizioni pedologiche, dalla coltura, dall’andamento meteo-climatico, dalla tecnica di distribuzione (l’interramento ad esempio è più efficace nel contrastare questo fenomeno), dalle quantità, dal tipo di azoto distribuito.
Efficace è anche l’introduzione nel concime ureico di sostanze che rallentano l’attività microbica nitrificante e denitrificante o che direttamente contrastano i fenomeni che portano alla liberazione di N2O. Sono tutti metodi che permettono di migliorare la Nitrogen Use Efficiency, che appunto valuta quanto dell’azoto distribuito è stato assorbito dalla pianta. Tutto questo spiega perché le colture leguminose (azotofissatrici) o quelle che possono sfruttare concimazioni di origine organica prodotta in azienda, vantano sotto questo profilo un grande vantaggio.
Nettamente distanziati seguono in ordine decrescente di impatto (ma ovviamente la graduatoria fra questi gruppi varia molto in funzione delle tecniche e dell’ambiente in cui sono applicate) troviamo gli altri input immessi nel processo produttivo, ma estranei all’azienda agricola (sostanzialmente fitofarmaci, sementi e materiali di consumo plastici e non), le lavorazioni del terreno, comprendendovi in queste anche la semina, la raccolta e il trasporto del prodotto a breve distanza e, infine, l’irrigazione.
Le operazioni di essiccazione non sono state inserite in questa alquanto indicativa graduatoria, perché effettivamente molto variabili e perché possono incidere notevolmente solo sui prodotti a raccolta autunnale.
Da questi dati sembrerebbe emergere che per ridurre le emissioni di gas climalteranti sia poco conveniente agire sulla meccanizzazione. Questo, invece, è un mezzo molto potente che consente di contrastare in misura significativa tali emissioni. Due sono le strategie disponibili: entrambe tecnicamente percorribili, entrambe con riflessi positivi sui costi di produzione e sul reddito, applicabili insieme e capaci di generare sinergie positive.
Sinergie fra conservativa e precisione
Una meccanizzazione che intersechi la conservativa con la precisione ottiene innanzitutto i vantaggi che derivano dalla somma dei benefici economici diretti offerti da queste due tecniche di gestione. Inoltre, ottiene i vantaggi che derivano dalle sinergie ecosistemiche che scaturiscono dall’intersecazione di queste due tecniche.
Per esempio, e come ricordato poc’anzi, l’adozione di pratiche conservative incrementa sul medio periodo il contenuto di sostanza organica del suolo; se contemporaneamente applico pratiche di rateo variabile che contribuiscono a ridurre gli sprechi di azoto, riduco anche il catabolismo a carico della sostanza organica stessa accelerando il suo accumulo.
La sostanza organica, a sua volta, porta a un adsorbimento maggiore dei composti azotati altrimenti velocemente lisciviati, ma li assorbe anche, incamerandoli per brevi lassi di tempo all’interno della biomassa edafica (in particolare nella sua fase viva) per poi rilasciarli e operare come un azotato a lenta cessione.